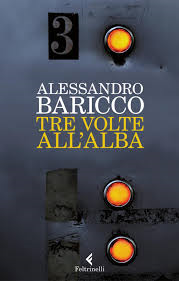Che cosa si può dire di una
ragazza morta a venticinque anni?
Ah, no, scusate, questo è l’incipit di un’altra celebre storia
d’amore. Quello che voglio dire è:
Che cosa si può dire di un
romanzo famoso del quale è già stato
detto tutto ma proprio tutto?
Che è un capolavoro. E intrigante. Che parla
d’amore e di ossessione. E di perversione. E dell’America. Scusate ancora, mi sono lasciato trascinare dal ricordo della Love Story di Erich Segal – chissà come mi sarà venuta in mente – e sto scrivendo
con lo stesso ritmo delle prime righe di quel romanzo (a questo punto lei
rispose sorridendo: «Alfabetico.»). Basta, stiamo parlando di un’altra donna.
Anzi, di una ragazzina.
Una ragazzina il cui vero
nome, nel romanzo, è Dolores Haze, ma in tutto il mondo è ormai celeberrima con
il nomignolo creatole dall’io narrante della storia, l’enigmatico letterato
europeo Humbert Humbert,
innamoratosi in modo folle di questa precoce dodicenne che lui chiama: Lolita.
Lolita. Un nome che, in seguito al successo del
libro e allo scalpore che ha suscitato in quel lontano 1955, è stato ormai
elevato al rango di archetipo di tutte le giovanissime maliziose e procaci che
fanno disperare lo sventurato talmente sfortunato da cadere innamorato di loro,
fino al punto di entrare a buon diritto come lemma nei dizionari: “Lolita: ragazza adolescente di aspetto
provocante, che suscita desideri sessuali anche in uomini adulti.” (De Mauro,
Il dizionario della Lingua Italiana, Paravia – fonte Wikipedia). Ma Humbert è
prossimo alla quarantina e questa differenza d’età, unitamente alla condizione
prepubere di Dolores, fa sì che un amore ossessivo come il suo non possa non
essere etichettato altro che pura pedofilia, soprattutto quando, dopo che quasi
per caso Humbert diventa il suo patrigno, tra i due si instaura un continuativo,
torbido e problematico rapporto sessuale.
Oltre al film che ne ha
tratto Stanley Kubrik, su Lolita sono stati scritti libri interi
e il romanzo stesso è stato adottato come libro di testo in diverse università per
studiarci sopra le problematiche psicologiche inerenti la sfera della
pedofilia. Ma potrebbe allo stesso modo essere adottato nelle facoltà
letterarie come esempio di uno stile di scrittura superbo, elegantissimo, ricco di sovrastrutture e di un patrimonio
di conoscenze tale da farlo inserire nell’Olimpo dell’Alta Letteratura.
Lo stile di Vladimir Nabokov è soggettivo e molto
sofisticato, dai periodi lunghi e ricchi di subordinate che l’autore giostra da
burattinaio esperto facendo loro compiere elaborate circonvoluzioni ritmate da
una sapiente punteggiatura. Nabokov ha scritto il romanzo direttamente in
inglese, e questo non deve stupire perché già dall’età di tre anni parlava la
lingua correntemente avendola imparata ancora prima del russo, e solo dieci
anni dopo ha tradotto egli stesso il romanzo nella lingua di Tolstoj (la quale
riesce meglio a rendere molte immagini e stati d’animo – parole dello stesso
Nabokov).
A qualcuno potrebbero
infastidire lo stile ricercatissimo e i ghirigori sintattici, le frequenti
deviazioni verso scene meno interessanti rispetto al rapporto principale, gli
abbellimenti, la prolissità dell’io narrante, le numerose citazioni in francese
o in latino, ma un consiglio che mi sento di darvi è di leggere il libro fino
in fondo, dopodiché vi sentirete gratificati e profondamente convinti di aver
letto un romanzo che davvero valeva
la pena di leggere: ce ne sono pochi, e questo è uno di quelli. Ad ogni pagina
si scopre qualcosa di nuovo, Nabokov mostra e non dice restando sempre fuori
dal linguaggio volgare, e il suo stile particolarissimo è reso splendidamente
dalla traduzione di Giulia Arborio Mella.
Pur essendo considerato un romanzo erotico, nel libro non c’è una sola parola
sconcia e non viene descritta neanche
una scena di sesso: i riferimenti ai momenti scabrosi sono solamente
allusivi, l’autore gioca con le parole in modo tale che il lettore è portato
solamente ad immaginarsi ciò che
succede tra i due protagonisti.
Quando Humbert spiega al
lettore le ragioni del suo comportamento ci si trova a parteggiare per lui nonostante ci si renda conto che è mosso da un
sentimento “sbagliato”, e nonostante le sue azioni criticabili non si riesce a
formulare un giudizio del tutto negativo sul protagonista perché si è ammaliati
dal suo racconto e dalle sofferenze causategli da questo amore torbido, da
questo sentimento ossessionante che lo porta a compiere gesti estremi. Come
Humbert, ci si sente messi da parte, umiliati
da questa ragazzina indifferente dalla mente rivolta in tutt’altre direzioni,
che provoca e si estrania, che ferisce e se ne disinteressa, e Nabokov rende in
modo incredibilmente incisivo sia i comportamenti innocenti ma nello stesso
tempo cinici di Lolita che i timori
e lo struggimento senza speranza del protagonista: “Quello che mi fa impazzire è la natura doppia di questa ninfetta – di
ogni ninfetta, forse; questo miscuglio, nella mia Lolita, di un’infantilità
tenera e sognante e di una sorta di raccapricciante volgarità…”. “Lei corazzava la sua vulnerabilità con la
trita sfacciataggine e la noia, (…) o mia povera bambina con l’anima pesta.”
Tratteggiando il rapporto
tra Humbert e Dolores, Nabokov ne approfitta per viaggiare attraverso gli Stati
Uniti della fine degli anni ’40 del secolo scorso e per descrivere i vari modi
di vita americani in un mosaico di cartoline che ne illustrano l’essenza: è
facile individuare a questo punto come il libro sia anche un parallelo tra la liaison dei protagonisti e la storia d’amore tra la matura Europa e
la giovane America (ma sarà Europa che tenta di circuire America, o sarà
America che provoca l’anziana Europa?), a fermare il concetto che un autore “non dovrebbe mai” scrivere allegorie, ma che l’opera stessa “deve” essere un’allegoria (per quest’ultimo pensiero ringraziate papà Hemingway).
Numerosi sono i brani
ricchi di una straordinaria potenza
narrativa: quando Humbert scopre la moglie intenta a leggere di nascosto il
suo diario segreto e la di lei successiva tragica fuga; il piangere dalla gioia per il “fato puntuale”; la
rivelazione delle esperienze sessuali precedenti di Dolores; la masochistica
ossessione di Humbert di essere pedinato da misteriosi personaggi; la
conclusione tragicomica di un omicidio trasformatosi in farsa e molti altri.
E non sono da sottovalutare
nemmeno la prefazione, scritta da Nabokov stesso sotto lo pseudonimo di
un fittizio John Ray, e che in
realtà è un vero e proprio prologo alla vicenda ricco di metonimie e arcane
anticipazioni, e la fantastica
postfazione nella quale l’autore, stavolta firmandosi in chiaro, spiega la
genesi del romanzo e nello stesso tempo fornisce un’incredibilmente dotta lezione di scrittura: “Nessuno scrittore, in un paese libero,
dovrebbe esser costretto a preoccuparsi dell’esatta linea di demarcazione tra
il sensuale e l’erotico…”; continuate a leggerla sul libro, vedrete che
merita.
Pur non essendo minimamente
interessato al tema della pedofilia – i bambini sono del tutto al di fuori dei
miei interessi, in tutti i campi –, da parecchio tempo covavo l’intenzione di iniziare
questo romanzo che aspettava da anni con pazienza il suo turno nello scaffale
dei libri da leggere. Inconsciamente me ne sentivo intimorito, forse a causa
dell’argomento ho avuto sempre parecchia ritrosia nell’affrontarlo. Ma se da
una parte potrebbe sorgere una specie di rammarico per essermi negato per tanto
tempo un così importante capolavoro, nello stesso tempo non rimpiango di non
averlo letto prima: con un bagaglio di esperienza più povero avrei di sicuro
apprezzato di meno tutte le prelibatezze che l’autore ha voluto metterci
dentro.
Il Lettore